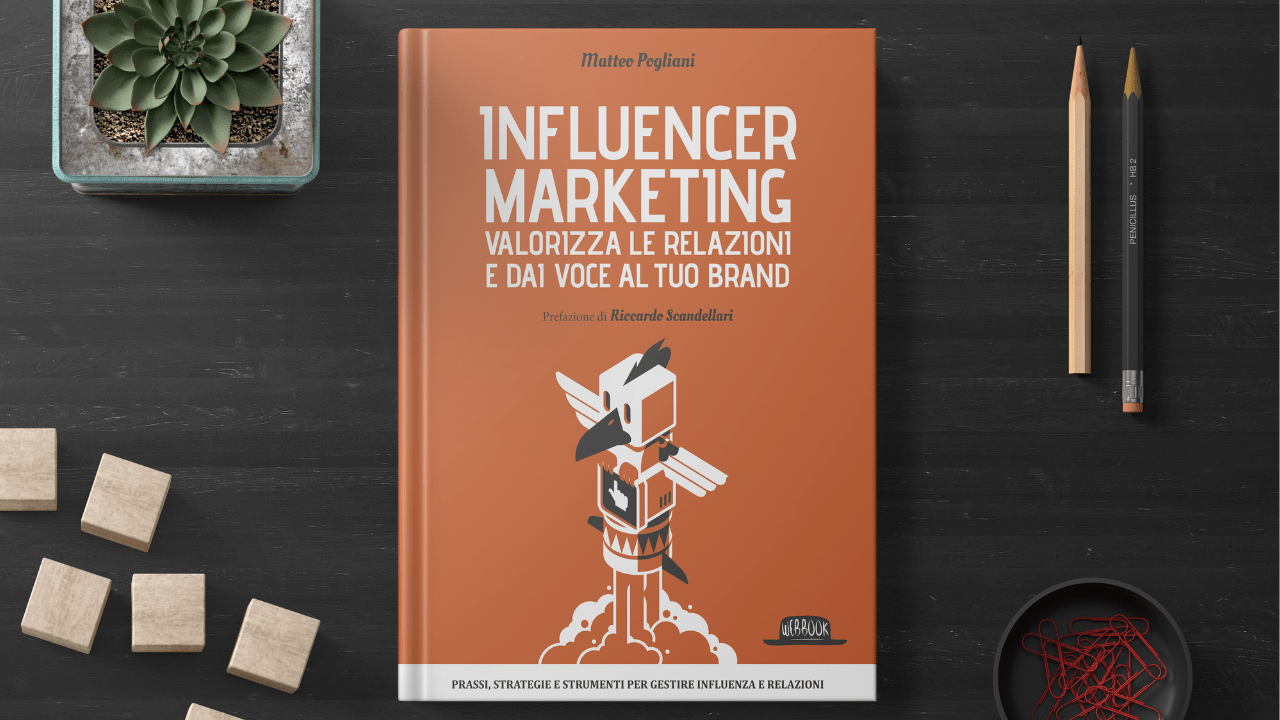Unicità. Una parola diventata mantra quando parliamo di comunicazione e che è diventata manifesto per tanti (troppi) marketer. Siamo infondo tutti figli di una mucca viola e lo scenario delle piattaforme digital ci ha spinto ancor di più in questa direzione, nel tentativo di vincere la battaglia per l’attenzione degli utenti, limitata costantemente dall’eccesso di stimoli e informazioni a cui sono sottoposti.
Essere unici significa soprattutto differenziarsi, sottolineando in maniera netta la nostra proposition rispetto ai competitor. Un modo per provare i vantaggi dei nostri prodotti e servizi a discapito degli altri. Ma siamo certi sia l’unica via?
Leggendo un post a riguardo dell’amico Alberto Maestri ho riflettuto come a volte, essere unici si traduce in diversità, nell’accezione non sempre positiva del termine. Perché diverso non fa sempre rima con ben accetto.
Una riflessione che ho voluto applicare al mondo digital.
Agli albori c’era il marketing dell’unicità
Lo dicevamo, l’approccio delle aziende e dei marketer è sempre stato orientato a evidenziare le differenze, in una costante rincorsa a generare un’identità e un’immagine forte (e originale) di marca. Un modo per essere sempre e comunque riconoscibile agli occhi dei diversi stakeholder, clienti in primis.
Differenziare è la keyword che guida la danza con un solo e unico obiettivo: essere unico e valorizzare l’uniqueness. Un gioco sapiente di asimmetrie trasversale per canali e strumenti, utile in ogni touchpoint a passare questo messaggio, rendendo sempre riconoscibile, seppur nelle differenze, il brand.
Un modus operandi che funzionava e che ancora vediamo anche nei canali digitali, social compresi, ma che in queste piattaforme ha iniziato ad essere valutato in modo critico, non più come obbligo. Una conseguenza che deriva dalla natura stessa di questi canali e dal tipo di comunicazione che qui si realizza. Contenuti mordi e fuggi, con u “tempo di vita” breve, fugaci e che costringe sì a colpire l’attenzione, ma anche a rendere estremamente comprensibile (e assimilabile) ciò che viene realizzato.
L’uso di stilemi diffusi è sicuramente in questo un aiuto, così come l’effetto community che sui social tende a omologare e a valorizzare le similitudini, prima che le differenze (pensiamo al plus dato dalla riprova sociale).
Unicità. Una parola diventata mantra quando parliamo di comunicazione e che è oggi manifesto per tanti (troppi) marketer. Siamo infondo tutti figli di una mucca viola e lo scenario delle piattaforme digital ci ha spinto ancor di più in questa direzione, nel tentativo di vincere la battaglia per l’attenzione degli utenti, limitata costantemente dall’eccesso di stimoli e informazioni a cui sono sottoposti.
Essere unici significa soprattutto differenziarsi, sottolineando in maniera netta la nostra proposition rispetto ai competitor. Un modo per provare i vantaggi dei nostri prodotti e servizi a discapito degli altri. Ma siamo certi che questa sia l’unica via?
Leggendo un post del mio amico Alberto Maestri al riguardo, ho riflettuto su come a volte, essere unici si traduce in diversità, nell’accezione non sempre positiva del termine. Perché diverso non fa sempre rima con ben accetto.
Una riflessione che ho voluto applicare al mondo digital.
Agli albori c’era il marketing dell’unicità
Lo dicevamo, l’approccio delle aziende e dei marketer è sempre stato orientato a evidenziare le differenze, in una costante rincorsa a generare un’identità e un’immagine forte (e originale) di marca. Un modo per essere riconoscibile agli occhi dei diversi stakeholder, clienti in primis.
Differenziarsi è la keyword che guida la danza con un solo e unico obiettivo: essere unico e valorizzare l’uniqueness. Un gioco sapiente di asimmetrie trasversale per canali e strumenti, utile in ogni touchpoint a passare questo messaggio, rendendo sempre identificabile, seppur nelle differenze, il brand.
Un modus operandi che funzionava e che ancora vediamo anche nei canali digitali, social compresi, ma che in queste piattaforme ha iniziato ad essere valutato in modo critico, non più come obbligo. Una conseguenza che deriva dalla natura stessa di questi canali e dal tipo di comunicazione che qui si realizza. Contenuti mordi e fuggi, fugaci, con un “tempo di vita” breve che costringe sì a colpire l’attenzione, ma anche a rendere estremamente comprensibile (e assimilabile) ciò che viene realizzato.L’uso di stilemi diffusi è sicuramente in questo un aiuto, così come l’effetto community che sui social tende a omologare e a valorizzare le similitudini, prima che le differenze (pensiamo al plus dato dalla riprova sociale).
L’uso di stilemi diffusi è sicuramente in questo un aiuto, così come l’effetto community che sui social tende a omologare e a valorizzare le similitudini, prima che le differenze (pensiamo al plus dato dalla riprova sociale).
La forza dell’uniformità
Comunità, gruppi e la spinta livellante della globalizzazione, dove tutti facciamo parte di un qualcosa di diffuso e comune. Una spinta che diventa inversa rispetto ai canoni dell’unicità e che si tramuta in volontà di uniformare, di far sentire parte, in cui le asimmetrie diventano tutto d’un tratto simmetrie.
Questo, soprattutto sui social, ha portato ad affiancare alla creatività, colei che governava il voler distinguersi, la capacità di sapere leggere dati e, ancor di più, le caratteristiche degli utenti, facendo emergere quegli elementi capaci di unire queste persone.
Non un copia incolla, quanto più una ricerca di mood e topic da poter applicare. Il focus è più sui comparable che sui competitor, realtà che non operano nel nostro stesso settore, ma che condividono elementi a caratteristiche dell’audience (lusso, lifestyle, ecc).
Un esempio in tal senso è la ricerca ossessiva del real time marketing, anche in circostanze lontane dal brand. Pensiamo ai tanti post social dei brand creati per la stagione finale di Game of Throne, la volontà non era legarsi alla serie o ai suoi temi, quanto sfruttare l’elemento collante e condiviso che la saga aveva creato nel grande pubblico. Un effetto sameness per generare inclusione.
L’equilibrio è tutto
È innegabile come l’appartenenza, soprattutto sui social, sappia essere un valore che sposta lato comunicazione. È capace di produrre performance e, in particolare, vanity metrics. Ma i brand non vivono di like ed è per questo che diventa necessario saper dosare le due anime, creando sì una community uniforme e coesa, ma anche riuscendo a far emergere ciò che rende la nostra marca unica, preferibile rispetto ad un’altra.
Perché in fase di scelta l’utente torna, anche solo in parte, singolo, valutando in base ai propri interessi. Se quindi nelle prime fasi della comunicazione la sameness è premiante è altrettanto vero che nel proseguimento della customer journey sarà l’uniqueness a guadagnare importanza e determinare la conversione.
Un equilibrio non sempre facile da trovare (e mantenere), ma che diventa decisivo per il successo del brand.